DA: “UNA CASALINGA AD HOLLYWOOD” DI STEFANIA APHEL BARZINI-EDIZIONI GUIDO TOMMASI
“I quindici giorni prima dell’arrivo dei miei figli furono quasi un corso accelerato di “americanità”. Volevo impossessarmi del Paese nel minor tempo possibile, volevo assimilarne tutte le sfumature per essere poi in grado di passarlo ai miei figli smussandone gli spigoli violenti ed ansiogeni. Volevo insomma “abituarmi”.
Mi abituai così al cielo, sempre implacabilmente azzurro, alla luce accecante, a tramonti rosso sangue, mi abituai alla pollution, all’inquinamento, che sfilaccia strisce giallastre all’orizzonte ma è completamente privo di odore. Mi abituai a certa finta gentilezza della gente, all’inevitabile “How you doing today? ” (Come va oggi?) che ti accoglie all’entrata di ogni negozio e all’altrettanto inevitabile “Have a nice day” (Ti auguro una buona giornata) che ti saluta all’uscita. Anche quando è chiaro che in realtà le commesse non sono affatto entusiaste di intrattenersi con te. Mi abituai a non poter camminare mai se non nei malls (una volta che passeggiavo per Bel Air, un poliziotto si informò con aria sospettosa di cosa stessi facendo fuori dall’automobile, vale a dire a Los Angeles, fuori dall’habitat naturale). Mi abituai alla paura che leggevo negli occhi della gente quando mi avvicinavo per chiedere un’informazione. Mi abituai alla straordinaria natura di quella città, ai suoi alberi sempre fioriti, ai coyote che si aggiravano nella mia strada alla ricerca di qualcosa da mangiare, ai falchi in picchiata in giardino dove facevano razzie di scoiattoli, puzzole e orsetti lavatori.
Los Angeles è stata strappata al deserto, al mare, alle montagne, a quella natura grandiosa e selvaggia che è l’anima vera dell’ America e del West in particolare.
Nel primo mese della mia vita americana il Los Angeles Times raccontava che gli abitanti degli smisurati sobborghi della città trovavano le loro piscine occupate da orsi in cerca di un pò di sollievo dalle temperature inclementi.
Mi abituai a trascorrere gran parte della giornata in macchina, a guidare sulle “freeways” americane e all’idea che per immettermi nell’autostrada, invece di rallentare, come si usa nel resto del mondo, dovevo invece accelerare per adeguarmi alla velocità delle altre automobili che sfrecciavano sulla strada.
Mi abituai al “disposal”, il congegno elettrico che vive come un piccolo animale carnivoro nel lavandino delle cucine americane nutrendosi dei vostri rifiuti domestici, e imparai che l’animaletto è goloso di bucce di patate, torsoli di mele e polvere di caffè e detesta carciofi, uova e gambi di sedano che andavano poi ad intasare come erbe maligne tutte le tubature della mia casa di Lassie. Mi abituai all’urlo continuo delle sirene della polizia, al rumore confuso della freeway, al rombo cupo degli elicotteri che giorno e notte pattugliano senza sosta la città.
In altre parole mi abituai a Los Angeles.
Nell’attesa dei miei figli cucinavo poco. Andavamo invece spesso al ristorante, un modo per farsi nuovi amici e conoscere la città.
Conoscere gente a Los Angeles è facile. Gli Americani hanno quell’istintiva socievolezza che ti mette immediatamente a tuo agio. Il problema è che spesso non si va oltre il primo facile contatto. Si resta lì, tra ampi sorrisi e grandi pacche sulle spalle. L’intimità, le confidenze, le lunghe chiacchiere notturne, in breve l’amicizia, quella che va coltivata con pazienza e difesa con coraggio, non sembra essere uno dei sentimenti che gli Americani adulti privilegino, di conseguenza quando si incontra qualcuno con le tue stesse esigenze affettive (e a Los Angeles si riconoscono a distanza come gli assetati che vagano nel deserto) ci si aggrappa uno all’altro come naufraghi su una zattera. A L.A. quando nasce una vera amicizia è per sempre. E’ quello che ci accadde con Martin, il nostro primo vero amico oltreoceano. Martin era un regista argentino, che aveva vissuto e lavorato a Londra e a Roma, prima di stabilirsi in California. Abitava sulle colline di Hollywood in quella che era stata la dimora di Jean Harlow e dove, assicurava, ancora si aggirava il suo fantasma accendendo e spegnendo luci. Con Martin si andava molto al cinema e a mangiare fuori. Fu lui a farci da guida nel primo, difficile mese americano. E fu sempre lui ad introdurci ai riti e ai misteri del “ristorante americano”.
I giornali raccontano che gli Americani nelle loro case cucinano sempre meno, tanto è vero che a New York è ormai difficile trovare case con la cucina e, se quelle che si trovano nelle ville di Los Angeles sembrano essere uscite dalle pagine di qualche rivista di design alla moda, è difficile credere che in tanta asettica perfezione qualcuno effetivamente si affatichi ai fornelli. Sono cucine disegnate per scongelare il cibo da riscaldare nel microonde. Cucine costruite per famiglie di gente che non mangia. Fa spuntini.
Il ristorante però è un’altra cosa. Gli Americani adorano andarci. E ce ne sono di tutti i tipi a dimostrare che l’America è un vero “melting pot”. Eppure a guardarla (e ad assaggiarla) troppo da vicino, questa cucina globale ha un sapore strano o meglio una preoccupante omogeneità. Il taco ha lo stesso sapore dell’hamburger e la pizza sa di tortilla.
I sapori del mondo vengono assimilati, controllati e rielaborati affinchè perdano i connotati originari e si trasformino in qualcosa di nuovo: cibo americano. Più che celebrare le differenze si preferisce provare che alla fine si è tutti uguali (anche gastronomicamente parlando).
Il cibo è un fortissimo strumento di identità e forse l’unico modo in cui milioni di persone, così diverse tra loro, come sono gli Americani, possano mangiare come un’ unica indivisibile entità, è consumare lo stesso tipo di cibo, il più inoffensivo e indefinito possibile.
E siccome in America è vero tutto ed anche il contrario di tutto, è anche vero che ci sono stati indimenticabili ristoranti giapponesi, coreani, indiani, thailandesi, cinesi durante i miei anni americani. E che i problemi maggiori li ho avuti con i ristoranti “americani” e quelli italiani ( o almeno sedicenti tali).
La mia “prima volta” al ristorante è stata con Martin, in un classico ristorante di cucina californiana a West Hollywood, la parte della città considerata più “hip”, più alla moda, un quartiere pieno di negozi, locali e ristorantini. Meno rarefatta e paludata dell’irraggiungibile Bel Air o della più scontata Beverly Hills, West Hollywood è, per così dire, l’anima “giovane” di Los Angeles.
Per cucina californiana si intende una sorta di fusion tra diverse tradizioni culinarie, quella mediterranea (un po’ di francese, un pizzico d’italiana, qualche suggestione spagnola), quella orientale in generale (cioè molte spezie) e quella messicana. Il tutto però rivisto e corretto secondo le mode del momento e con un forte accento sui prodotti locali, verdure in particolare. I risultati sono discontinui. Se lo chef è persona equilibrata (se cioè sa dosare saggiamente tecniche, fantasia e ingredienti) i piatti che assaggerete si riveleranno autentiche sorprese. Se invece lo chef è a briglia sciolta (e ahimè capita spesso), allora il pasto si trasforma in un’irriconoscibile accozzaglia di sapori diversi messi insieme con un unico scopo: colpire il vostro palato il più duramente possibile, tramortirlo con poca grazia.
Tutto questo però, al mio ingresso nel ristorante, non lo sapevo. Né sapevo che sarei stata ostaggio del cameriere. A L.A. camerieri ( e cameriere) sono tutti belli e palestrati. Il fatto è che in realtà non sono affatto camerieri. Sono aspiranti attori, registi, sceneggiatori, scrittori, e questo spiega molte cose. Spiega per esempio perché siano sempre così sorridenti e ansiosi di conquistarti (non si sa mai, potresti essere un agente, un cast director o forse un produttore).
Il mio cameriere, quella volta (e anche quelle successive), mi si catapultò addosso annunciandomi “Ciao! Come va oggi? Mi chiamo John e stasera sono qui per te”.
Se da un lato ero lusingata da quella che pensavo essere un’attenzione particolare nei miei confronti, dall’altro ero vagamente sconcertata da quell’eccessiva confidenza. John non ci mollò un istante per il resto della serata, provvido di consigli e di attenzioni non richieste. Alla fine della cena ero pronta ad assalirlo con la gigantesca pepiera che mi era stata messa a disposizione, altro indispensabile oggetto di arredo di ogni ristorante americano che si rispetti.
Appena seduta al tavolo, il solerte John mi parò davanti un bicchiere (formato boccale da birra) di cubetti di ghiaccio. Questo, scoprii in seguito, è un servizio standard. Si presume insomma che tu sia assetato e forse anche disidratato. Se ciò è forse comprensibile a Los Angeles o in Arizona in agosto, dove le temperature medie sono piuttosto alte, lo è meno in Alaska a dicembre. Comunque il bibitone ghiacciato è inevitabile, per quanto abbia tentato infatti non sono mai riuscita a fermarlo in tempo. Arriva prima che ci si sia accomodati sulla sedia.
In rapida successione spuntarono poi il pane e una ciotola di burro, in anni più recenti (e più “gastronomically correct”) sostituita da olio e sale. John tornò con il menu e ci elencò gli “specials”, vale a dire i suoi piatti favoriti del giorno. Per dispetto ordinai tutt’altro. E mi trovai ad affrontare le straordinarie possibilità di un menu americano.
Per prima cosa è bene sapere che, qualunque sia il piatto prescelto, sarà comunque enorme. Poi che, se ordinate un “Main dish”, un piatto forte, di solito carne o pesce, vi verranno comunque affibbiati un’insalata o la zuppa del giorno. Infine preparatevi ad affrontare il pasto vero e proprio. E, se lo affronterete senza pregiudizi ne avrete in cambio piacevoli sorprese. Perché non è affatto vero, come pensa la maggior parte degli Italiani, che il cibo americano fa tutto schifo.
Ho sempre letto storie di scrittori, chef, critici gastronomici americani, folgorati sulla via di Damasco al loro primo pasto in terra straniera (di solito la Francia). Io credo di essere una di quelle poche che hanno avuto epifanie gastronomiche al contrario. In America ho scoperto alcuni dei miei piatti preferiti di tutti i tempi. Per esempio il gumbo e la jambalaya a New Orleans, straordinarie zuppe stufate a base di riso e carne. O ancora il “corn bread”, pane di granturco e il pollo fritto degli Stati del sud, solo per citarne alcuni. La cucina “povera” americana, quella regionale, se fatta bene e con ingredienti di qualità, non è forse sofisticata e varia come le grandi cucine del mondo, ma è di quelle che allargano il cuore, come un buon piatto di pasta o polpette ben fatte da noi”.
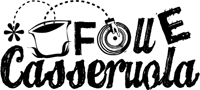

No Comments