DA” COSI’ MANGIAVAMO” DI STEFANIA APHEL BARZINI-EDIZIONI GAMBERO ROSSO.
“La fame non faceva parte del mio quotidiano di bambina degli anni ’50 ma il principio che niente dovesse essere sprecato quello si’, un atteggiamento che ho in comune con tutta la generazione cosiddetta dei “baby boomers”, vale a dire quella nata negli anni successivi alla guerra. Nelle nostre case non si buttava via nulla e soprattutto si finiva tutto cio’ che era nel piatto. In particolare io ricordo il fegato che e’ stata una delle tragedie gastronomiche della mia infanzia.
Per qualche motivo nelle nostre famiglie ancora segnate da anni di fame e denutrizione, forte era la convinzione che quella che si affacciava al mondo sarebbe stata una generazione gracile, fiacca, stenterella. Cosi’ pervicace era questa certezza, che la si ritrovava persino nelle pagine di uno dei libri cult della mia infanzia. Piu’ che un libro per bambini uno spaventoso compendio di atrocita’. Parlo di Pierino Porcospino. Ognuno di noi fratelli aveva le sue storie preferite, di quelle che di notte si trasformavano in incubi. C’era chi sveniva alla sola vista di “Corrado che si succhia il dito”, al quale un simpatico sarto armato di forbici gigantesche tranciava di netto i pollici, chi invece era piu’ sensibile a “Filippo che si dondola”, che finiva paralizzato perche’ a furia di oscillare precipitava a terra spezzandosi la schiena, e chi, come me, era particolarmente impressionato da “Giacomino era un bambino molto vispo e birichino che mangiava ogni mattina con piacer la minestrina”, questo Giacomino, per motivi a noi oscuri e in grande anticipo sui tempi, diventava inspiegabilmente anoressico, decidendo un bel giorno che “no, la minestra non la vo”, smetteva cosi’ di mangiare la sua zuppa diventando ogni giorno piu’ magro, fino ad essere spazzato via da un colpo di vento. Sulla sua tomba, a imperitura memoria, non fiori ma una grande zuppiera.
Quelli erano tempi in cui grassezza era ancora bellezza e avere ciccia voleva dire stare in buona salute e aver debellato, una volta per tutte, l’inquietante spauracchio della fame.
Per mia madre questo spauracchio poteva essere annientato con un solo magico ingrediente: il fegato, assunto in qualsiasi forma.
Si iniziava appena svegli, ancora mezzi intontiti dal sonno, quando venivamo costretti da medici sadici a mandar giu’ l’obbligatoria dose di olio di fegato di merluzzo. Questo accadeva ancor prima di affrontare la colazione tipo degli anni ’50: zuppa di pane e latte, alternata a quella di latte e biscotti, dove per biscotti si intendevano unicamente gli immangiabili (se non per l’appunto sciolti nel latte) Petit Beurre, piatte gallette prive di qualsiasi appeal, secche, poco zuccherate, dal vago retrogusto di segatura. Ad ogni modo, chi abbia assaggiato l’orribile, denso, maleodorante sciroppo di olio di fegato di merluzzo sa di cosa parlo. Un supplizio, e uno dei peggiori. Lo tenevo in bocca per ore, perche’ mi era impossibile costringere il cervello a emettere l’ordine di inghiottire; quando poi finalmente riuscivo a mandar giu’, venivo scossa da immancabili conati di vomito che cercavo disperatamente di reprimere, cosciente com’ero che se cio’ non fosse accaduto, avrei dovuto sottopormi di nuovo alla tortura.
A pranzo poi, spesso e volentieri, appariva anche il fegato in persona, duro, pieno di nervi, assolutamente immangiabile. Non c’era pero’ verso di evitarlo, mia madre era capace di restare ore ad osservare mentre, come uno scoiattolo, mi riempivo la bocca di pezzi dell’odiata fettina che masticavo e rimasticavo a lungo finche’ con sforzo sovrumano, a occhi chiusi, inghiottivo quell’imbarazzante bolo. Oltretutto ad accompagnare i miei disgraziati tentativi c’erano anche le spaventose storie narratemi ad imperituro esempio, di come da bambina, piatti da lei detestati, le venissero riproposti a volte anche per giorni, fino al momento della resa che doveva essere totale e incondizionata. E non finiva qui, la sera, prima di dormire, con scadenza piu’ o meno trimestrale, c’era anche la terapia ricostituente a base di dolorose iniezioni di estratti di fegato. Non sapro’ mai se questo accanimento abbia realmente sortito qualche risultato: cosa sarebbe accaduto di me se non avessi assimilato quelle mostruose dosi di fegato? E’ un’incognita della mia vita che non trovera’ risposta.
Fortunatamente giunse anche il momento in cui mia madre fu costretta ad abbandonare il campo, arrendendosi definitivamente : sono stata l’unica della famiglia a cui, forse per disperazione, fu permesso di interrompere il consumo di fegato in padella, privilegio mai concesso a nessuno dei miei fratelli. Uno dei tanti vantaggi dell’essere la maggiore e l’unica femmina”.
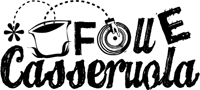

No Comments