DA: “UNA CASALINGA AD HOLLYWOOD” DI STEFANIA BARZINI-EDIZIONI TOMMASI
Malgrado il sole, la vita tranquilla e gli amici sempre più numerosi, ogni tanto, prepotentemente, si faceva sentire la nostalgia di casa.
Non mi vergogno di dire che, come in una pessima soap opera, mi capitava di ritrovarmi in lacrime ascoltando delle vecchie cassette di Antonello Venditti che si sdilinquiva su Villa Borghese. Oppure che , guidando sulla freeway, mi ritrovassi a cantare a squarciagola le peggiori canzoni di Eros Ramazzotti sotto gli sguardi spaventati degli altri automobilisti.
A Los Angeles in macchina non si canta, e non si fanno molte altre cose. Altrimenti passi per pazzo e come tale, potenzialmente pericoloso.
A me piace molto osservare la gente ai semafori, sono quei brevi momenti di pausa in cui di solito ci si rilassa. Nella mia città , fermi al semaforo, si parla al telefonino, si fuma una sigaretta o ci si fanno spudoratamente i fatti degli altri. Insomma ci si guarda molto. A Los Angeles invece esiste una legge non scritta che vieta tutto ciò. Guardarsi, come tra i branchi di gorilla, è considerato una sfida, una forma di aggressione e se capita per sbaglio meglio abbassare subito lo sguardo. In compenso sono consentite altre attività. La principale, e lo dico dopo attenta osservazione, è scaccolarsi. Non so perché ma i Losangelini amano farlo soprattutto ai semafori. L’altra è mangiare, o bere.
La nostalgia di casa si manifestava anche sotto mentite spoglie. Per esempio al cinema. Una sera andai con amici a vedere “Big Night” allora appena uscito. Per chi non l’avesse visto il film racconta la storia di due fratelli italo-americani che decidono di aprire un ristorante a New York. Il fratello chef è un puro che non vuole accettare, gastronomicamente parlando, alcun compromesso, l’altro invece sarebbe disposto a scendere a patti pur di far funzionare il locale. Vale a dire via libera a spaghetti con le polpette e linguine vongole e parmigiano. Nel film , il simbolo della “resistenza culinaria” alle mode americane è rappresentato da un fantastico timballo di pasta. Lo chef impiega due giorni a preparalo, curandolo come se si trattasse di un bambino. Gli spettatori intorno a me emettevano gorgoglii di piacere mentre pensavano in quale ristorante italiano finire la serata. Io, oltre ad una fame smodata, avevo un nodo in gola. La sindrome da emigrante, valigia con lo spago e bastimento di terza classe, colpiva duro. Tutto quello che riuscivo a pensare, come ET era :”Casa! Casa!”.
Per noi Italiani il cibo è stato ed è tuttora un fortissimo simbolo di identità culturale, di appartenenza. Me ne ero accorta quando, l’Istituto Italiano di Cultura mi aveva chiesto un aiuto per organizzare una serie di eventi e in particolare di occuparmi della parte “mangereccia” di questi eventi. Mi ero così ritrovata a preparare cappelletti per 300 persone e soprattutto, a grande richiesta delle masse, teglie su teglie di lasagne al forno.
Le lasagne erano ambite soprattutto dagli Italo-americani, un gruppo compatto capace di consumare pantagrueliche quantità di cibo. Una volta uno di loro era riuscito a mangiarne sei porzioni in soli trenta minuti. La settima l’aveva avvolta in un pezzo di carta e se l’era messa in tasca. Quando si era ripresentato per un ottavo giro avevo cercato di bloccarlo : “Mi sembra che possa bastare, non vorrei che si sentisse male e poi mi facesse causa!”
Fare causa infatti era un altro degli sport preferiti degli americani, si faceva causa per i motivi più bizzarri; l’ultimo in ordine di tempo era stato il caso di una giovane signora che aveva denunciato il farmacista del suo paese reo di averle venduto un gel anticoncezionale. La signora, tornata a casa, aveva spalmato il gel su un toast, se lo era mangiato, e poi era volata tra le braccia dell’ amato bene certa di fare cosi’ sesso sicuro. Naturalmente si era ritrovata incinta. La richiesta di risarcimento era di mezzo milione di dollari perche’ malgrado il foglietto delle istruzioni specificasse le modalita’ d’uso, la signora sosteneva che il farmacista avrebbe dovuto specificare che il gel non era commestibile perche’ “ in quei momenti” chi ha il tempo e la voglia di leggere? Non ho mai saputo il seguito della vicenda.
Al mio avvertimento invece l’italo-americano in questione aveva risposto con uno sguardo carico di risentimento e di orgoglio ferito:” Lei non capisce, per me la lasagna è casa!” .
Invece capivo perfettamente tanto è vero che nei momenti in cui la lontananza da casa si faceva più acuta, passavo giornate intere a girovagare nei negozi di alimentari italiani. Niente mi consolava di più della vista di zamponi e ravioli.
Il mio massimo di resistenza continuativa fuori d’Italia variava dagli otto ai dieci mesi. Poi cominciavo a scalpitare, mi si stringeva lo stomaco e aumentavano esponenzialmente le ore passate gorgheggiando canzonette italiane e passeggiando tra cotechini e panettoni.
Il primo anno non tornai in Italia per 13 mesi. Quando arrivai a Roma era giugno, la città era in fiore, la gente passeggiava per le strade, tutto mi sembrava meraviglioso. Per prima cosa svegliandomi la mattina mi precipitai al bar dove in rapida sequenza bevvi tre cappuccini e mangiai sei cornetti. La vita cominciava a sorridermi. Poi passai dal fornaio per comprare la pizza bianca. Quella romana che deve essere nè troppo morbida né troppo croccante, né troppo alta né troppo bassa, unta al punto giusto e con i grani di sale duro in superficie. E infine al mercato per il companatico: mortadella e ricotta da infilare nella pizza.
E fu proprio lì, tra le urla dei commercianti, il profumo dolce dei grossi mazzi di basilico, quello pungente della rughetta selvatica, tra bancarelle traboccanti di pomodori e zucchine, che mi sentii finalmente a casa. Da quel momento ogni volta che tornavo in Italia per prima cosa mi precipitavo al mercato. Mi aggiravo come in trance tra i banchi comprando tutto ciò che solleticava la mia attenzione e il mio naso: mozzarelle e ricotte, vongole e gamberoni, puntarelle e broccoletti. Non ero mai sazia, più acquistavo e più come per magia, quel senso vago di spaesamento, quell’ansia sottile che mi assaliva ad ogni mio ritorno, si scioglieva come neve al sole. Il mercato, come per incantesimo, ricomponeva radici e identità.
Dopo le visite al mercato i miei ritorni a Los Angeles erano più facili. Ripartivo, come una vera emigrante, con valige cariche di cibo. Portavo qualsiasi cosa, formaggi, insaccati, mezze forme di parmigiano reggiano, marmellate, farine, funghi secchi, caffè. Far entrare cibo e semi negli USA è considerato un reato punibile dalla legge. Le regole in materia non scherzano. I miei ritorni avevano sempre (almeno per me) qualcosa di eroico. Mi sentivo la Mata Hari della salsiccia, la 007 del culatello, la Osama bin Laden del parmigiano.
Una volta c’ero andata pesante, delle tre valige che riportavo in America, due erano cariche di cibo. Avevo esagerato. C’era di tutto, soprattutto quantità spropositate di zafferano che a Los Angeles si trovava raramente e a prezzi stratosferici ( da Gelson’s un tubetto costava tredici dollari ed era conservato chiuso a chiave sotto teca, quasi si trattasse di uno dei gioielli del Topkapi). Immaginavo per me un fulgido avvenire di “pusher” di zafferano negli Stati Uniti, ero nervosissima, sapevo che se mi avessero scoperta avrei passato un brutto momento. Mi avvicinai con passo sicuro al banco della dogana. “Niente da dichiarare?” mi chiese il funzionario americano. “Assolutamente niente” risposi con un sorriso smagliante. “Da dove viene?”. “Dall’Italia.” A questo punto il solerte funzionario mi fisso dritto negli occhi e mi sussurrò con l’aria di chi la sa lunga: “Ah…dall’Italia….e non porta nulla eh?…”. Arrossii violentemente. Ero stata beccata senza neanche aprire le valige! E il peggio era che io sapevo che lui sapeva che io sapevo. Anni di poveri emigranti italiani di ritorno dalla madrepatria con caciotte e salsicce avevano lasciato il segno. Balbettai qualcosa ma stranamente il doganiere (chissà forse figlio anche lui di emigranti), chinò leggermente il capo e disse: “Vada pure e buon appetito”. Era andata.
La stessa cosa accadde anni dopo a Chiara, che tornava a New York con tre salami calabresi in valigia. Quella volta i salami furono scoperti e mia figlia, colpita negli affetti più cari, si mise quasi a piangere implorando:”La prego, sono il regalo di compleanno dei miei genitori!”. La sceneggiata funzionò: i salami erano salvi.
Il desiderio (soprattutto appena tornata dall’Italia), di cucinare e mangiare verdure che avessero un qualche sapore, mi spinse a cercare i Farmer’s Market del mio quartiere, alla lettera i “mercati dei contadini”. Erano un fenomeno abba stanza recente in America che si stava spandendo a macchia d’olio, soprattutto a Los Angeles sempre così “politically correct”.
La “politically correctness” o quanto meno l’uso eccessivo che se ne faceva, era, secondo me, uno dei veri mali americani del secolo. Parlare era diventata un’attività pericolosa e nel tentativo di non offendere nessuno, in un paese di gente evidentemente molto permalosa e suscettibile, o soltanto priva di sense of humour, bisognava prestare la massima attenzione alla scelta delle parole. Tutto questo nascondeva la vera questione e cioè che usando il vocabolo sbagliato ci si poteva arricchire, e molto. In nome del “politically correct” infatti venivano vinte cause miliardarie. Questo fenomeno aveva non solo cambiato (e in peggio) i rapporti tra la gente, ma aveva soprattutto trasformato, con risultati a volte irresistibili, la lingua americana. Eccovene qualche esempio.
Oggi non si è più vecchi, si è “cronologicamente dotati”
Non si è più poveri, si è “economicamente marginalizzati”
Non si è più grassi, si è ” gravitazionalmente compromessi”
Non si è più brutti, si è “cosmeticamente diversi”
Non si è più disonesti, si è “eticamente disorientati”
Non si ha più un brutto naso, si è “nasalmente svantaggiati”
Non si vive nel ghetto ma in “un’area etnicamente omogenea”
Fino ad arrivare ai miei preferiti: le donne non sono incinta, sono “parassiticamente oppresse”. E la carne non è tale ma “carcassa animale lavorata”. Un’idea allegra sia della gravidanza che della carne!
A me i Farmer’s market piacevano molto, erano quanto di più simile ai mercati europei esistesse in America, la frutta e la verdura erano sicuramente più fresche e soprattutto più buone di quelle in bella mostra al supermercato, e anche se quello del mio quartiere non offriva una grande varietà di prodotti, mi piaceva però quell’atmosfera un pò da fiera paesana: la musica country , le vecchie signore che vendevano golfini per neonati fatti a mano, il grosso gallo multicolore che starnazzava acuto. L’unico aspetto che mi infastidiva era proprio quella fastidiosa nota di “politically correct”.
In particolare mi disturbavano le uova. Ce ne erano di tutti i tipi e di tutte le grandezze, d’oca e di gallina, bianche, marroni e azzurrine. Su esse troneggiava un cartello che recitava che tutte erano state “humanly treated”, trattate con umanità. Cosa voleva dire? Che le galline erano state allevate nei prati? O che avevano ascoltato musica? Oppure che gli allevatori passavano le loro giornate ad accarezzare le uova?
Gli americani adorano gli animali e non mi avrebbe perciò sorpreso sapere che il muscoloso signore che stava dietro al banchetto trascorresse il suo tempo a baciare in bocca le galline ovaiole. Non è che mi dispiacesse questa passione animalesca. Anzi. Al mio paese ogni estate si consumavano stragi di animali abbandonati sulle strade dai loro padroni desiderosi di vacanza, ero perciò l’ultima ad avere voce in capitolo. Però ogni tanto la passione sconfinava.
I giornali erano pieni di annunci che pubblicizzavano i prodotti più assurdi: da dolcetti a forma di osso per la festa di Halloween, ad occhiali da sole per gatti. Una pensione per animali annunciava trionfante di essere la prima ad offrire “Cat Tv”, la televisione per gatti: un acquario da 5000 litri pieno di pesci multicolori e una delle più grandi compagnie aeree proponeva poi un programma “frequent flier” per animali: ogni dieci viaggi uno in omaggio.
A Los Angeles c’erano ospedali veterinari che curavano i nostri amici a quattro zampe con le erbe, l’agopuntura e l’omeopatia. Il capitano Haggerty, un signore pelato che sorrideva sulle pagine di tutti i giornali, affermava di poter addestrare qualsiasi cane in soli due giorni con il metodo zen: “Un metodo nuovo, unico, dolce, olistico, che vi aiuterà a vivere in armonia con il vostro animale”. C’erano psichiatri, ipnotisti, guaritori per animali. A volte avevo addirittura l’impressione che gli americani avessero più a cuore le sorti dei loro cani di quelle dei loro famigliari.
E poi c’era il Los Angeles Pet Memorial Park, il cimitero dei piccoli animali domestici a Calabasas, un sobborgo di L.A. C’ero capitata quasi per caso in un giorno di esplorazione nelle periferie della città. Era un vero cimitero con tanto di tombe, lapidi, ceri e vasi di fiori. E siccome eravamo a Los Angeles molti animali famosi avevano trovato li’ l’ eterno riposo: Boots, il gatto di Charlie Chaplin , Kabar, il cane di Rodolfo Valentino, Droopy, quello di Humphrey Bogart e persino la scimmia di Mae West che però non aveva nome. Accanto alle “stars” c’erano anche animali più umili, criceti, iguane e persino Blinky, l’amichevole gallina, nata nel 1976 e morta nel 1978, come recitava la lapide sulla sua tomba. Sandy, la custode del cimitero mi aveva anche fornito una serie di depliants illustrativi dal titolo “The Proper Good- Bye”, l’addio migliore, dove mi si spiegava che per seppellire il mio animaletto avrei speso circa 500 dollari inclusivi di bara (un contenitore in plastica foderato di satin), sepoltura e l’installazione permanente di un vaso di fiori. Per un prezzo aggiuntivo avrei anche potuto scegliere una lapide in granito con la scritta adatta.
Dopo la visita al Los Angeles Pet Memorial Park mi rifiutai di mangiare polli per una settimana.
I venti giorni seguenti ad ogni mio ritorno dall’Italia cercavo disperatamente di riprodurre la mia terra cucinando verdure e condendo insalate. Non che fosse difficile, i Californiani le adorano, sono facili da preparare anche per chi non s’intende di cucina e soprattutto sono versatili, danno ampio spazio alla fantasia. Anche a quella più sfrenata. Così a Los Angeles l’insalata impazza. Sono lontani gli anni della “iceberg salad”, quella specie di lattugona dura e insapore onnipresente per decenni sulle tavole americane. Adesso l’ultimo grido è “baby and wild”, piccola e selvatica. Piccole e selvatiche sono tutte le insalate che si acquistano, pulite e lavate, al supermercato in buste già confezionate. Non hanno un gran sapore ma hanno il vantaggio di poter restare nel vostro frigorifeero per settimane senza mai appassire. Quanto al gusto ci pensano i “dressings”, i condimenti. Li potete trovare imbottigliati in qualsiasi negozio, ce n’è per tutti i gusti: ranch, french, italian, mexican, blue cheese. Uno è con le erbe, l’altro con la senape, l’altro ancora con il formaggio. Tutti hanno lo stesso sapore di aglio chimico. Quasi nessuno prevede l’aggiunta di olio d’oliva. Alla lattuga (o agli spinaci crudi, anch’essi “baby”), si aggiungono poi ingredienti a piacere, immancabili i crostini di pane, possibilmente insaporiti alle erbe o al parmigiano, inevitabili caprino, noci, kiwi e avocado e pomodori essiccati. Nei ristoranti di lusso sono di rigore radicchio e aceto balsamico (o aceto di lamponi), petto di quaglia e funghi selvatici. Il pezzo forte resta però la Caesar’s salad, una ricchissima insalata., un piatto amato dai più e percio’ considerato dai gourmet un pò troppo rozzo, da cafoni, e invece se ben preparata si tratta di un’autentica squisitezza, non un contorno ma un vero e proprio piatto a sè”.
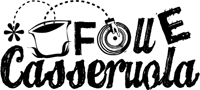

No Comments