DA: “UNA CASALINGA AD HOLLYWOOD” DI STEFANIA BARZINI-GUIDO TOMMASI EDITORE
“A casa mia tentavo di far argine alla barbarie gastronomica americana. “Qui si parla e si mangia italiano”, avevo decretato. Chiara, da sempre una buona forchetta, aveva aderito al programma con entusiasmo. Matteo invece dirazzava. Nella sua ansia di uniformarsi e diventare un vero americano, aveva deciso di condividere con i suoi amici anche e soprattutto i pasti. Il fast food per lui non aveva segreti. Li conosceva tutti e teneva una sua lista personale: agli ultimi posti spiccava MacDonald, preceduto da Taco Bell, Jack in the Box, Burghy King, per arrivare a Subway (un fast food finto salutista perché usava finte baguette invece dei soliti panini) e inarrivabile, in testa a tutti, Carl’s Junior. Sebbene non sia una khomeinista gastronomica (anzi ammetto che due o tre volte l’anno capitava anche a me di buttarmi con entusiasmo sul panino maledetto e soprattutto nutrivo un’insana passione per le quesadillas al formaggio di Taco Bell, un fast food messicano), non riuscivo però a capire i motivi dell’entusiasmo di mio figlio, la gioia con cui strappava a grossi morsi il suo Famous Big Star, no onions, no pickles and extra tomatoes (niente cipolle, niente sottaceti e pomodori extra). Li consumava rigorosamente in macchina in osservanza alla regola californiana secondo la quale mangiare e bere in automobile risparmia tempo e denaro. Fu però proprio Carl’s Junior a salvare Matteo dalla prigione (o meglio da una salata multa).
Tra gli amici di Matteo nessuno aveva una madre cucinante, una categoria rarissima (tanto che una volta Sean, il migliore amico di Matteo, arrivò trafelato a casa per annunciarmi emozionato che Leslie, sua madre,la sera prima aveva cucinato uno stufato, cosa che non accadeva da anni), e non avevano neanche l’abitudine di sedersi intorno ad un tavolo per mangiare. I pasti avvenivano in fretta e a orari diversi: arrivavano a casa chi dalla scuola, chi dal lavoro, aprivano il (gigantesco) frigorifero e sbattevano nel microonde vassoietti precotti o merende surgelate. Intorno alla mia tavola invece accadevano fatti strani: gli amici di mio figlio, sempre presenti ad ora di cena ci osservavano stupefatti, tutta quella gente seduta, la tovaglia, bicchieri e posate, piatti strani passati da uno all’altro. Non si capacitavano, come un branco di lupi che accerchino la preda si avvicinavano ogni giorno di più. Capivo che erano imbarazzati e incuriositi allo stesso tempo. Per mesi ho cercato di attirarli con il cibo, non si fidavano. Finalmente un giorno Sean cedette di fronte ad un piatto di spaghetti con le melanzane. Fu il crollo della diga. Uno a uno si sedettero tutti quanti. E non si rialzarono mai più. Da quel momento in poi a cena c’erano sempre almeno due o tre amici dei miei figli e quando partivo per le vacanze i saluti erano strazianti. Non avrebbero sentito la mia mancanza ma quella della mia cucina. O meglio quella della cucina. Si erano abituati a mangiare altro e adesso sarebbe stato difficile tornare indietro. L’unico che non riuscii a convertire fu Kevin. Non ho mai conosciuto un palato più refrattario alle novità. Kevin era un tossicomane da macaroni and cheese e hamburger, gli unici due piatti che avesse mangiato in vita sua e anche gli unici ingredienti che fosse in grado di riconoscere. Una volta gli preparai gli straccetti con il rosmarino, che mangiò senza entusiasmo. Non riusciva a credere che fosse carne. Per lui “carne” era solo hamburger e solo quella voleva. Proprio come un vero tossicomane.
Diverso era invece il rapporto con gli amici di Chiara, erano più grandi e anche più curiosi. Ben in particolare il primo amico di mia figlia in terra straniera, ci aveva accolti con entusiasmo, noi e quello che mangiavamo. Gli piaceva mangiare e, cosa ancora più rara per uno della sua età adorava cucinare. Spesso mi seguiva in cucina e in breve divenne uno di famiglia. Il mio figlio americano. Tanto che ce lo portammo con noi in Italia dove lavora in un ristorante. Il mio maggior successo. Ducky, una ragazza cicciotella dall’andatura a papera (da cui il nomignolo ducky) arrivava invece ogni mattina all’alba. Abitava lontano così veniva da noi che poi l’accompagnavamo a scuola con i miei figli. Dal primo giorno Ducky (anche la sua famiglia era di quelle disastrate: madre che aveva lasciato il marito per un’altra donna, il padre si era risposato con una signora con prole facendo di lei una moderna Cenerentola), aveva deciso che in noi aveva trovato una nuova tribù e ciò comportava che ogni giorno, verso le sei, entrasse trionfalmente nella nostra stanza e ci si infilasse nel letto. Eravamo, ci diceva contenta, la sua “mama” e il suo “papa”. Poi faceva colazione, cornetti, caffè e marmellata e solo allora si poteva andare a scuola.
La notizia che a casa mia si cucinava si sparse presto con il risultato che tutte le domeniche un gruppo variabile di persone (dai dieci in su) si autoinvitava a pranzo. C’era un po’ di tutto, amici italiani nostalgici della cucina di casa, amici americani desiderosi di famiglia, amici dei miei figli ansiosi di interrompere per un giorno la dieta “fast food” a cui si sottoponevano nel resto della settimana. E tutti sembravano apprezzare. Al punto che con il passare del tempo addirittura mi arrivavano richieste specifiche: “Per me la pizza di formaggio”, “ Potresti farmi la pasta con le zucchine?” “Vorremmo la torta di limone” . Ognuno aveva le sue preferenze che io cercavo di accontentare. Il ruolo di nutrice e cuciniera mi dava grandi soddisfazioni, la fatica non mi spaventava. Quello che mi pesava invece era il dover tener conto delle tante idiosincrasie alimentari dei miei ospiti. E a Los Angeles sono tutti allergici a qualcosa. C’erano i vegetariani (un folto gruppo) che non mangiavano carne, c’erano gli integralisti (i vegan), non solo niente carne ma anche no alle uova, al formaggio, al pesce. C’erano quelli che non mangiavano i funghi e quelli che non amavano gli asparagi. C’era il gruppo in difesa delle ostriche, quello in difesa dei conigli, quello per la salvaguardia dei crostacei. Un elenco infinito che rendeva particolarmente complicato organizzare un menu che accontentasse tutti. La pasta metteva tutti d’accordo, ne preparavo quantità impressionanti perlopiù con le verdure. Poi, malgrado i vegetariani, andavano fortissimo la genovese, il sartù di riso e le lasagne, l’emblema stesso della cucina italiana all’estero. La genovese, una ricetta napoletana a base di carne e cipolle con cui poi si condisce la pasta, era il piatto preferito di John, un attore americo-cubano che ogni volta che ne mangiava mi ripeteva con le lacrime agli occhi che gli ricordava un piatto che la mamma gli preparava da bambino a Cuba (sarei curiosa di capire quale). Emily, sua moglie, un esempio perfetto di “wasp” ( white,anglo saxon, protestant), quegli americani, discendenti dai Padri Pellegrini, bianchi, anglosassoni e protestanti, amava invece il risotto con le zucchine. Faceva la cuoca a domicilio, e questo a Los Angeles voleva dire cucinare per le star, e le star erano pronte a sborsare cifre esorbitanti per un piatto di spaghetti pomodoro e basilico. Emily infatti aveva clienti celebri: John Travolta e la moglie, Bruce Springsteen, Warren Beatty e soprattutto Madonna. Io ero curiosissima di sapere quali erano i piatti preferiti di tutte queste celebrità ma Emily era abbottonatissima, avevo scoperto solo che a John Travolta non piacevano le uova, che il Boss era di gusti semplici anche a tavola. Che Warren Beatty era molto attento alla linea e richiedeva soprattutto verdure. E poi c’era Madonna per la quale, come in una versione gastronomica di Cenerentola, avevo cucinato per una notte. Era successo che una sera Emily le aveva magnificato un risotto con le zucchine mangiato a casa mia qualche giorno prima. Niente di particolarmente eccitante ma il risotto era appena arrivato sulle tavole americane e improvvisamente tutti mangiavano risotto, soprattutto se con le verdure. Madonna aveva chiesto di assaggiare questo decantato risotto ma Emily non sapeva cucinarlo e così mi aveva chiamato bisbigliando dalla cucina dell’attrice: “Puoi preparare il risotto alle zucchine per telefono? Non voglio fare brutta figura! Tu mi dai le istruzioni e io eseguo…” E così mi ero ritrovata a cucinare per telefono. Il risotto aveva riscosso un tale successo che Emily (con onestà tipicamente americana) non se l’era sentita di prendersi tutto il merito e così aveva confessato i “dietro le quinte”. “Madonna vorrebbe che le cucinassi un pranzo italiano” mi chiese esitante Emily il giorno dopo. Dissi di no. Non volevo rubare il mestiere alla mia amica. E così si concluse la mia breve ma brillante carriera di chef delle dive.
Poi c’era Katrina, nata in America ma di famiglia cubana, aveva dirazzato con grande dolore dei suoi genitori, quando aveva deciso di diventare vegetariana e nonostante questo mi raccontava di pranzi pantagruelici in famiglia a base di maialini interi arrostiti sotto la brace in grande buche in giardino. Kaz amava il pesto e non era la sola. Sembrava che gli Americani non conoscessero altro condimento e lo mettevano dappertutto, a proposito e a sproposito: pasta al pesto, crostini con il pesto, risotti con il pesto, arrosti al pesto, pesto nelle zuppe e nelle insalate. Un incubo a cui non si sfuggiva. Kaz era in grado di preparare solo insalate e uova strapazzate. Aveva un rapporto con il cibo tipicamente americano. Non è che non le piacesse mangiare ma lo faceva sempre con un vago senso di colpa e punendosi poi con stravaganti bibitoni a base di erbe e vitamine in polvere. Visto l’entusiasmo mostrato per il pesto avevo deciso di insegnarle a prepararselo da sola. La versione facile di un piatto già di per sè non troppo complicato. Basilico, pinoli, pecorino, aglio, olio, un frullatore, vroom: pesto. ” Molto difficile…”- aveva mormorato sconsolata scuotendo la testa. Non avevo insistito. E poi c’era Valeria. Valeria viveva tra l’Italia e l’America e, cosa rara per un’attrice, mangiava, tanto e con vera gioia. Mi piaceva guardarla mangiare perchè ogni volta aveva un rituale tutto suo. Si preparava il piatto con cura, mangiandolo prima con gli occhi, poi sistemava il pane, il bicchiere, aggiungeva il parmigiano o il sale, e quando finalmente otteneva (anche esteticamente) il risultato che cercava si buttava con entusiasmo sul piatto. Mi dava grandi soddisfazioni. In mezzo a tanti americani che in genere consideravano imbarazzante apprezzare troppo apertamente ciò che si mangia e soprattutto parlare di cibo a tavola( di peggio, e neanche tanto, c’è solo parlare di sesso a pranzo), Valeria sottolineava con entusiasmo tutto quello che aveva davanti. Valeria amava mangiare e lo faceva con allegria. Come tutto il resto d’altronde. L’avevo vista di cattivo umore solo due volte. La prima di fronte a uno dei tanti bibitoni vitaminici di Kaz, l’aveva preso come un affronto personale. La seconda quando una sera avevo dato al cane l’ultima fetta di salame che aveva sul piatto. Mi aveva affrontato con occhi scintillanti di rabbia: “Non si fa questo, non dovevi farlo!” mi aveva detto furiosa. Pensavo che scherzasse invece era serissima, capii che stava già assaporando nella sua mente quell’ultima, preziosa, fetta di salame ed io perfidamente le avevo negato un vero piacere. Chiara, mia figlia, aveva le stesse reazioni estreme di fronte al cibo, sarebbe stata capace di uccidere per l’ultima forchettata di pasta e tutt’oggi, in situazioni disperate sono certa che non esiterebbe a trasformarsi in cannibale. Dopo il “fattaccio del salame” mi convinsi che Valeria farebbe lo stesso.
Le giornate scorrevano tranquille, io ero felice di cucinare e i miei amici erano felici di mangiare quello che io cucinavo.
Los Angeles cominciava a piacermi.
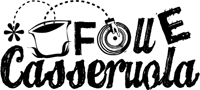

No Comments